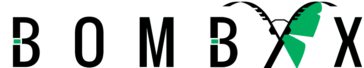L’idea da cui parte il progetto Bombyx si fonda sulla convinzione che la tutela, meglio ancora, la conservazione della natura sia un problema di carattere tecnico-scientifico, e quindi di conoscenza da un lato, ma anche un problema di carattere culturale-comportamentale, e dunque di consapevolezza. L’informazione sui temi dell’ambiente, intesa come condivisione della conoscenza del territorio e delle relative problematiche, influenza i comportamenti e gli atteggiamenti dei singoli individui, modificarne i modelli culturali di riferimento, incidendo sull’etica e motivandoli alla partecipazione attiva e consapevolezza. Purtroppo, negli ultimi anni il grande vuoto lasciato dall’assenza della educazione ambientale formale nelle nostre scuole è stato colmato da un’informazione disomogenea, proveniente prevalentemente dal web, a volte improvvisata e caratterizzata da clamorose contraddizioni, se non addirittura da convinzioni scientificamente infondate. La comunicazione dei social fa confusione, spesso non apre dibattiti seri e non consente la riflessione, genera invece divergenze improduttive e la divulgazione virale può persino arrivare ad enfatizzare dati falsi. La rete non ha mai avuto un chiaro ruolo dichiaratamente educativo, ma i messaggi che trasmette potrebbero essere pervasivi e generare misconcezioni, che si sa, sono molto difficili da contrastare o sradicare. Non ha aiutato di certo la politicizzazione delle campagne ambientali su temi che dovrebbero essere per definizioni apolitici. Dobbiamo, inoltre, ammettere che il persistere di opposizioni di principio di una certa politica, anche dinanzi a opere percepite come utili dalla maggioranza dei cittadini, ha ridotto nel tempo la capacità di influenzare l’opinione pubblica, da parte delle associazioni ambientaliste – e di tutti coloro che si battono sui temi dell’ambiente – le quali, nell’attuale situazione, non riescono più a svolgere in maniera adeguata la loro missione.
In competizione con i social, a mano a mano che la gravità dell’emergenza ambientale è aumentata, molta parte dei media tradizionali si sono soffermati sempre di più sull’aspetto drammatico, evidenziando il lato spettacolare delle catastrofi naturali e occupandosi di ambiente solo in caso di disastri eccezionali. L’informazione in materia ambientale di tipo scientifico, che include temi di difficile comprensione per la maggioranza delle persone, di frequente va ad orientarsi al sensazionalismo. Così oggi i temi dell’ambiente ricevono un’attenzione variabile e, molto spesso, superficiale, causando un’assuefazione alla notizia con la conseguente riduzione di credibilità dell’informazione stessa. Vince la logica dell’audience come quella dei like. Senza contare che dall’inquinamento all’abusivismo edilizio, dalle esondazioni alle alluvioni, ormai i contesti in cui appare la parola “ambiente” hanno una connotazione totalmente negativa. Neppure i molti spazi dedicati dalle tv pubbliche e private ai documentari sulla natura, pur riuscendo a migliorare la cultura degli spettatori, riescono a contrastare questa deviazione e a orientare in maniera concreta l’opinione del pubblico. Ciò che si verifica è che anche se apparentemente l’attenzione per i temi ambientali è più alta e si riconosce finalmente che il grave problema ambientale va affrontato e risolto, in realtà queste stesse dichiarazioni diventano slogan senza valore, soltanto enunciati vuoti, ispirati veramente a ideali elevati ma che non corrispondono a vere pratiche di realizzazioni e tanto meno a decisioni concrete.
Eppure, tra il mondo della comunicazione caotica, la rete con i suoi modernissimi social, priva di regole e il mondo strutturato tecnico-scientifico in genere, finanche quello accademico, troviamo punti di vista e contenuti informativi di elevato valore, fonti dirette di diversa origine, voci che si disperdono e spesso, naufragano. L’intento, pertanto, è costruire uno strumento per non perdersi e per migliorare la propria capacità di orientarsi nella difficile scelta delle informazioni circolanti creando un recapito finale a un certo tipo di informazione, imbrigliando e incanalando sensibilità e competenze multiple, cercando di intercettare professionisti, accademici, rappresentanti delle istituzioni e della comunità scientifica in genere. Il progetto nasce da questa esigenza di fornire uno spazio specifico per i temi ambientali alle nuove forme diversificate di informazioni e di ricerca, che si stanno affermando grazie all’open data e alla divulgazione attraverso i social. Di dare la percezione concreta che “la scienza è di tutti” e “può essere per tutti” purché vi sia un grado concreto di “umiltà della comprensione e della divulgazione” tra lo scienziato, il divulgatore e il cittadino. Nel nostro progetto, quindi, al centro c’è il cittadino che diventa consapevole attraverso divulgazioni “comprensibili”, che può applicare in modo migliore le nozioni e informazioni acquisite. Una scienza che tenga conto della base della comunità e che tiene bada gli impulsi negativi di una “elitè degli scenziati” che hanno allontanato il cittadino dalla scienza stessa.
Ma siamo consapevoli che, se informare sulle questioni ambientali è compito arduo e implica un peso, una responsabilità, esso necessita anche di un approccio, per così dire, strategico. Nella gestione delle problematiche di un territorio, inteso come il risultato della complessa rete di relazioni che si instaurano nel tempo fra l’azione dell’uomo e la natura che lo circonda, divulgare le informazioni correttamente vuol dire educare allo scopo di innescare processi di tutela dell’ambiente. Strategicamente, è evidente che sia necessario spostare il baricentro dell’attenzione dalla spettacolarità all’approfondimento della complessità delle dinamiche degli eventi naturali e dei fattori antropici come concause della catastrofe per l’uomo. La strategia di informazione, educazione e comunicazione che intendiamo adottare è finalizzata prima di tutto a ricostruire il nostro rapporto individuale con il territorio e poi come collettività, cercando di contribuire alla crescita di un’opinione pubblica consapevole delle proprie responsabilità e diritti, al fine di facilitare una più ampia e cosciente partecipazione ai processi politici e alla gestione del territorio. Informare sulla storia e l’evoluzione del territorio rafforza il senso di appartenenza al proprio ambiente e, in tal senso, insegna a comprenderlo, riconoscendone gli eventuali segni di sofferenza e può indirizzare nella individuazione di scenari di cambiamento, al fine di porre rimedio al malessere rilevato. Non abbiamo ancora la ricetta perfetta, ma conosciamo bene gli ingredienti: imparare, fare, sperare. E qui dove siamo nati, nella terra del fiume Sarno, che include i territori di tre province, Napoli, Avellino e Salerno, dove si avanza in aria di catastrofe, l’emergenza nei millenni ha probabilmente contaminato la nostra stessa identità e ha forgiato la nostra resilienza, quella qualità che oscilla tra l’adattamento e la caparbietà a voler restare ad abitare un luogo, a un passo dal Vesuvio, dove la convivenza con la natura è più dura e difficile. E’ proprio questa qualità che nei millenni non è mai stata cancellata né da terremoti, né da alluvioni, né da aeromoti, inondazioni e devastazioni di ogni genere, ed è il valore legato al concetto di resilienza che recuperiamo il giorno dopo il disastro per ricominciare a ricostruire le cose e quella stessa quotidianità che avevamo prima. Non si tratta soltanto della reazione positiva che si manifesta attraverso la ricostruzione di strade, ponti ed edifici, ma anche e soprattutto della capacità di guardare il futuro dalle macerie, trasportando la speranza oltre l’emergenza. In altri termini, imparando a ricostruire non soltanto le abitazioni, ma anche a conservare l’identità. E’ da qui che immaginiamo di iniziare il progetto, dalla nostra terra, dalla nostra resilienza, dalla nostra esistenza e resistenza in tempo di emergenze, imparando, agendo e sperando in un futuro migliore.