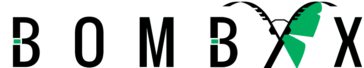La collana editoriale “Studi Storici Sarnesi”, presieduta dal prof. Gérard Delille già Direttore degli studi per l’Età Moderna e Contemporanea presso L’École Française de Rome, ha recentemente inaugurato una nuova serie, gli “Opuscula Sarnensia”, dando alle stampe il libro di Alfonso Liguori Rossi “La Valle dei Mulini. Storia. Memorie” (Sarno, Edizioni Buonaiuto, 2021, ISBN 978-8-88-571439-7, pp. 158, ill.). L’opusculum in questione apre una serie di volumi tematici che la collana ha dedicato alla storia dell’ambiente e del territorio campano, alcuni dei quali già in corso di stampa.
Il libro ci parla di un territorio, quello di Sarno, che fu centrale negli equilibri del Regno tanto da un punto di vista geografico, rientrando in una fascia prossima alla capitale, quanto economico, essendo irrorato in ogni dove da sorgive, pozzi, rivi e fiumiciattoli, la cui forza motrice fu alla base di tutta la protoindustria dell’epoca medievale e moderna.
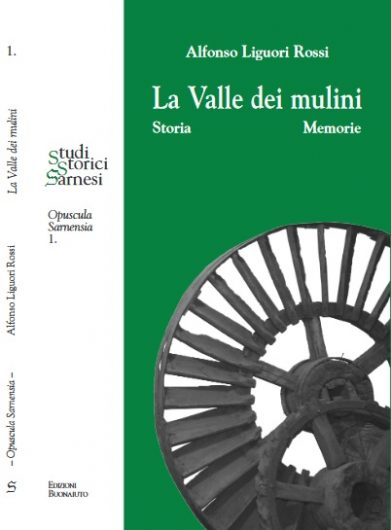
Lo studio è preceduto da una introduzione di Alfredo Franco, direttore responsabile della collana, dove è presentata questa nuova iniziativa editoriale ed è contestualizzata l’opera dell’a. Sono fornite le chiavi di lettura possibili di questa ricerca, anche in relazione all’inveterato problema dell’uso delle acque, al loro carattere pubblico, e alla loro indispensabilità per l’azienda signorile e il fabbisogno delle popolazioni (pp. 9-19).
L’indagine si divide nelle due sezioni “Storia” (pp. 21-80) e “Memorie” (pp. 99-152), come informa il sottotitolo.
Per la prima sezione l’a. si affida a testi ormai consolidati per ripercorrere il cammino che porta dal mortaio al mulino, non apportando grossi elementi di discussione a quanto già noto. Il discorso affronta diverse testimonianze disseminate lungo l’arco dei millenni, dalla Genesi all’Antico Egitto, da Strabone a Vitruvio, fino all’epoca tardoantica, quando a Barbégal, in Francia meridionale, erano attivi ben 16 mulini con ruote che dovevano servire ad una popolazione stimata in diverse decine di migliaia. Da questo punto si passa poi al regime di “bannalità”, proprio del sistema feudale che si alimentava proprio grazie alle industrie presenti sul territorio (Cap. 1, pp. 23-30).
La città di Sarno assume in seguito il ruolo di argomento principale del discorso, e sono qui elencate tutte le testimonianze che fanno del sarnese la Valle dei Mulini essendo tutta l’area letteralmente disseminata da impianti di molitura: dal centro cittadino alla periferica Foce, alla borgata di Lavorate dove se ne riscontrano ben tre nello spazio di meno di un miglio lungo il rivo Santa Marina, fino a Casatori e San Valentino, centri satellite della vicina cittadina salernitana. La storia parte dalla prima epoca normanna, quando nel 1092 la famiglia comitale locale cede alla badia di Cava un opificio al Forunculus, cioè nel centro dell’abitato dove si teneva il mercato. La collocazione non era casuale perché all’alba del XII secolo in tutta la piana campana si assiste ad un progressivo inurbamento della popolazione in pianura, segno di una maggiore sicurezza dei tempi e dell’aumentato numero di abitanti. Oltre a questo mulino ve n’erano diversi nella località Foce, che presto entrano nel patrimonio delle grandi abbazie (come Montevergine), della mensa vescovile e dei signori. Le popolazioni stentano a rivendicare i diritti sulle acque e sulle strutture annesse in conseguenza ad un regime giuridico favorevole ai ceti dirigenti e ad un plurisecolare condizionamento politico. Da questi attori contrapposti, i signori da un lato e le popolazioni dall’altro, furono animate molte cause nell’arco di oltre duecento anni, tanto che ancora la copiosa documentazione ottocentesca custodita nel fornito archivio comunale della cittadina salernitana fa riferimento ai diritti sulle acque, alla proprietà dei mulini e ai diritti dei cittadini. Ancora nell’Ottocento il Comune di Sarno cercava una difficile negoziazione per garantire i diritti di tutti: popolazione, concessionari e conduttori dei mulini, vecchi proprietari degli impianti feudali (Cap. 2, pp. 31-62).
La sezione relativa alla Storia si chiude con la descrizione e la storia dei tre mulini più documentati, quello di Rio Palazzo, quello di Rio Santa Marina e quello della località Fraina (Cap. 3, pp. 63-80).
Interessante è pure la sezione iconografica, dove si possono reperire fotografie di archivio e attuali dei mulini e alcuni documenti utilizzati dall’a. nella sua ricerca (pp. 83-98).
Nella seconda parte, che agli occhi di uno storico è forse meno rilevante, sono tratteggiati gli ultimi mugnai artigiani dell’area sarnese: Enrico, Michele, Giulia, Pasquale (pp. 101-151). Ogni racconto contribuisce al quadro di una comunità di certo non secondaria della Campania, proprio in considerazione della prossimità a Napoli, la principale città del Meridione. Il secolo che descrivono è il Novecento, a partire dal contadino arruolatosi assieme ai Ragazzi del ’99 e ritornato dal fronte inabile al lavoro, alle perquisizioni e al sacco condotto dalle milizie fasciste nei casolari, fino al tramonto del secolo. Tra le varie, queste ultime biografie assumono più colore, in quanto i racconti sono provenienti dalla costola rurale della cittadina salernitana, la frazione di Lavorate. Qui sono testimoniati ancora fresche nel ricordo le pratiche tipiche della vita attorno ad un mulino, che non era da intendersi soltanto come un opificio ma come centro di tutta una comunità che dalla sua resa dipendeva. Là, attorno ad esso, si svolgeva la vita dei mestieranti, dei contadini e dei ragazzi che erano incuriositi ed ammaliati dal processo di trasformazione del grano in macinato: «era troppo interessante per loro, vedere quel prezioso frutto della terra mentre, con sacchi gonfi, veniva scaricato nei grossi imbuti delle tramogge, ed era troppo entusiasmante ed avvincente assistere alla trasformazione in polvere bianche che, come neve soffice, si depositava per ogni dove. La si respirava quella polvere: entrava nelle narici, attraversava le papille gustative, entrava negli occhi e pervadeva ogni poro della pelle» (p.143).
In questa seconda sezione il racconto si sofferma sugli aspetti più caratteristici e peculiari della vita in un borgo contadino alle prese con l’incipiente modernità che, proprio a cavallo tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, sarebbe entrata di prepotenza nei cortili, nelle viottole campestri, nelle case coloniche ed avrebbe cambiato per sempre quel mondo fatto di rituali antichi, di gesti abitudinari e del rapporto quotidiano con la natura. Un blocco di racconti che, di certo, darà opportunità di ulteriori approfondimenti a quanti si occupano di sociologia e di antropologia in chiave storica.